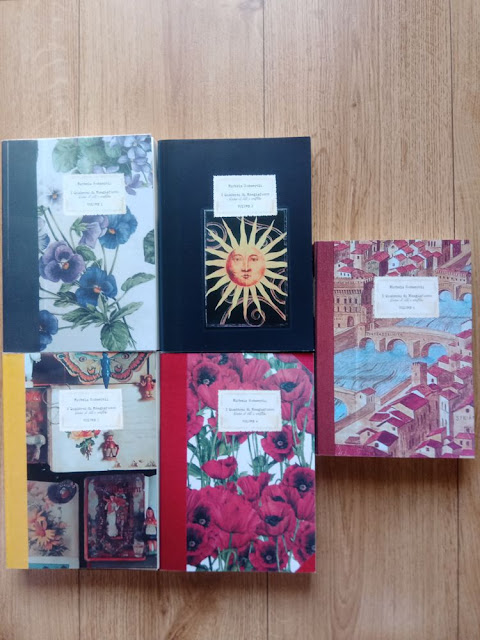Il mio romanzo sei tu (Raffaelli 2019)
Il mio romanzo sei tu (Raffaelli 2019)
Questo romanzo è dedicato a Roberto, al nostro incontro all’Università di Padova, e ai primi sedici anni vissuti a Milano, in via Faravelli. Dove abbiamo messo le basi del nostro rapporto, fra difficoltà e diversità che non hanno spento la voglia di stare assieme.
 |
| Il matrimonio con Roberto |
Anzi, come dice lui, sono stati gli anni più belli. Infatti è nata allora la mia scrittura, strettamente intrecciata all’ala benefica che la presenza quotidiana di Roberto, non sempre facile, ha steso intorno a me, dandomi la sicurezza, l’affetto di cui avevo bisogno. Il libro si chiude con la postfazione di Saverio Falcone, il mio analista junghiano di Milano. Una chiusura reale e simbolica, che ha suggellato, in maniera davvero speciale, il nostro percorso analitico, ciò che era rimasto sospeso, quando mi sono trasferita a Treviso.
1) Lettera a Roberto:
Carissimo,
chissà se sarò capace di dirti quello che provo, non è la sincerità che mi manca ma lo spazio, più difficile ormai da ricavare nel quotidiano.
La scrittura è sempre uno strumento utile, però non ho più immagini che la sorreggono: al loro posto una trincea vuota, una stanza in disuso, dove non so se si affaccerà ancora qualcosa.
Non erano così le mie speranze, ricordi?
Tuttavia ciò che più rimpiango è l’intensità che abbiamo vissuto assieme.
Quante volte mi è sembrata una condanna, uno stile poco adatto a stare bene, mentre adesso capisco che era un modo con cui ho tentato di non farmi scappare nulla.
In parte, credo di esserci riuscita sebbene mi ritrovi con un dolore in più: l’intransigenza del ricordo che non mi dà tregua, pur riempiendomi.
A questa intensità tu hai sempre contrapposto l’idea di una vita più normale.
Non so se più reale, benché la parola ‘realtà’ sia sempre stata un tuo cavallo di battaglia.
Quanto l’ho odiata quando cercavo di spiegarti la mia diversità e, adesso che mi hai accettato, non per questo mi sento più reale, nemmeno più normale.
Ma cos’è oggi la mia diversità? Forse è solo la mia storia, ciò che gettando indietro lo sguardo mi compare.
Sta di fatto che, con l’andare del tempo, questa mia storia, questa mia diversità si è ancor più denudata, senza sapere bene cosa sia questa nudità, se non il senso di precarietà che continuamente mi accompagna.
Ecco, questa è sicuramente la nostra diversità.
Quando tu non mi capivi, che sofferenza tradivano i tuoi occhi, e che angoscia c’era in me.
Ora sento che tutta la fatica che abbiamo fatto per avvicinarci ha partorito qualcosa che, nella sua fragilità, mi appare indistruttibile.
Il nostro pesantissimo bagaglio, tutto accatastato in un recesso interiore, è una specie di zavorra che, inspiegabilmente, non ci porta a fondo.
Forse perché le nostre mete materiali sono sempre state vaghe, nonostante tu dica di essere così concreto.
Mi viene da ridere se ci penso!
In altri momenti mi arrabbio, poi mi calmo, ma restiamo sempre battaglieri: abbiamo ancora troppi lati esposti a qualche raffica che ci colpisce duramente.
Come ho invidiato, in quei momenti, le coppie serene, pacate, in grado di risolvere ogni problema, speranzose, efficienti e, perché no?, con, alle spalle, famiglie benestanti e disponibili.
Noi a quarant’anni suonati, non possediamo che una storia travagliata!
Questa lettera, però, non vuole fare solo il punto di una situazione complicata, ma scoprire i lati migliori che emergono quando riusciamo a essere davvero consapevoli di noi stessi e, in questa consapevolezza, bastanti.
A tale proposito ho infiniti ricordi dei viaggi lungo il perimetro della nostra vita, un paesaggio così intimo, amato, da essere come un figlio.
Quanto lo abbiamo esplorato, assieme ai nostri luoghi di provenienza, alle nostre infanzie, alla nostra giovinezza.
Quando rifletto sul perché la nostra coppia è così improduttiva all’esterno, penso che questo limite sia una sorta di autosufficienza.
Dove avremmo potuto trovare, e dare, più ascolto, più stimoli?
Dove avremmo potuto percorrere più strade, non potendo mai raggiungere, come dice Eraclito, i confini dell’anima?
E delle ombre.
Su questo non ci siamo mai fatti illusioni, abbiamo sempre saputo di non poter incarnare alcun modello ideale, luminoso.
Ultimamente non ne soffro più: posso distinguere fra il desiderio e quello che c’è, l’immaginazione e la realtà.
Amarti è sapere quanto sia stato disperato, sproporzionato, il mio bisogno di te e forse, anche per questo, il nostro rapporto è stanco, logorato.
Però, appena la memoria si riscalda, entriamo nel pozzo del nostro passato e tu incontri subito me, io te.
 |
| Presentazione con Antonietta |
2) Il mio romanzo sei tu, di Michela Gusmeroli
La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda
e come la si ricorda per raccontarla (Gabriel Garcia Márquez)
Gli storici, scrisse Aristotele ((Poetica, 51b), parlano di quello
che è stato (del vero), i poeti di quello che avrebbe potuto esse-
re (del possibile). Ma naturalmente il vero è un punto d’arrivo,
non un punto di partenza. Gli storici (e, in modo diverso, i poe-
ti) fanno per mestiere qualcosa che è parte della vita di tutti:
districare l’intreccio di vero, falso, finto che è la trama del nos-
tro stare al mondo. (Carlo Ginzburg)
L’autobiografia si situa a metà strada - o le ricomprende entrambe - tra storia e narrazione. Potrei essere d’accordo con Carlo Ginzburg quando afferma che “La storia è una narrazione di fatti realmente accaduti e la narrazione è una storia di fatti che sarebbero potuti accadere”.
Ma questo pregevole testo, che il lettore - ne sono sicuro - saprà apprezzare per le sue qualità letterarie, è davvero un’autobiografia? La scelta del titolo, Il mio romanzo sei tu, è spiazzante, lascia perplessi, fa pensare. Perché non Il mio romanzo sono io? Chi è questo tu? Il marito? O la me stessa oggetto del racconto di un’altra me stessa, l’io narrante? Le due Michela: quella della vita là fuori (la vita vissuta, il mondo esterno) e quella della vita qui dentro (la vita trasfigurata, il mondo interiore)? Così anche del marito, che nel racconto è la spalla per così dire dell’attrice principale, si potrebbe pensare tanto a un uomo reale, in carne e ossa, quanto a una figura della psiche di Michela, una personificazione letteraria delle sue proiezioni maschili inconsce, quelle che Jung ha chiamato Animus.
Per sciogliere i dubbi chiediamo aiuto a Eubilide, filosofo greco dei tempi di Platone, che ci viene in soccorso con il suo famoso sofisma detto enkekalymnenos (il velato): “Sei capace di riconoscere tuo padre? Sì. Sei capace di riconoscere questo individuo velato? No. Ti contraddici, poiché questa persona velata è tuo padre. Tu quindi sei capace e incapace a un tempo di riconoscere tuo padre”. In altre parole, l’arte è il velo che posto sulla faccia nota della luna ne disvela la faccia nascosta, mostrando la luna (l’essere) nella sua totalità.
I grandi scrittori non coincidono necessariamente con i narratori di grandi eventi. Non è per questo che lo sono. I grandi scrittori sono coloro che possiedono (o per meglio dire sono posseduti da) un ingrediente speciale (chiamato con molti nomi: ispirazione, vocazione, talento, daimon) da cui sono agiti, talvolta anche contro la loro stessa volontà egoica, in contrasto, cioè, con la superficiale coscienza e conoscenza che hanno di se stessi. Questo ingrediente è la capacità di raccontare della banalità del vivere o di fatti che sconvolsero il mondo liberandosi della lente deformante di una visione della realtà fondata sul dualismo.
Così, l’immateriale leggerezza di una farfalla può convivere, anzi fondersi, nello stesso testo, con la greve pesantezza di una lastra di marmo. L’aut aut cede il passo all’et et. “Come sopra così sotto”, insegna l’arte dell’antica alchimia.
Nel mio racconto, scrive l’autrice, non c’è “Niente che si possa considerare più reale di un fatto immaginario” e anche, aggiungerei, come in uno specchio: “Niente che si possa considerare più immaginario di un fatto reale”. È dunque l’oltrepassamento del dualismo che fa di questa storia di ordinaria e faticosa normalità, del tutto simile a mille altre che ci parlano di persone sbattute dalla risacca del destino nell’angolo della marginalità, una storia letteraria di sorprendente bellezza.
Le esperienze precoci, chiamate imprinting, rimangono indelebilmente impresse nell’anima di ciascuno di noi. Quando ci feriscono, sono crepe che intaccano le radici profonde del nostro essere. Gli psicoanalisti le chiamano complessi. Il complesso è una specie di Giano bifronte: è sì il nostro male oscuro ma è anche la nostra diversità, ciò che ci rende unici e irripetibili. Possiamo agirlo o esserne agiti. Dipende da noi. Oppure possiamo scegliere una terza via: farlo diventare una leva creativa aprendo un varco comunicativo tra conscio e inconscio. Un dialogo che porta al superamento delle unilateralità, al tertium non datur, all’unione degli opposti, alla trascendenza...
Un particolare che ha sempre impressionato (...) il mio analista, riguarda la posizione del collegio. L’edificio, infatti, confinava con l’albergo dei miei e, quando tornavo da scuola, passavo davanti al portone dell’entrata. Gettavo lo sguardo nel buio dell’androne e, in fondo, appariva il chiarore della porta a vetri che immetteva nell’atrio.
Quanto avrei voluto sgattaiolare via, infilarmi dentro di corsa e ritrovare, per un attimo, i miei. Invece, restavo nella fila sorvegliata dalla suora, superavo il portone, raggiungevo il cancello del collegio e lo attraversavo come una qualsiasi educanda.
Come erano terribili quei pochi metri!
Poiché dovevo reprimere un immenso desiderio, e ricacciarlo nell’involucro del mio giovanissimo io.
Un cucciolo, di qualsiasi specie, può morire di qualsiasi cosa, ma non può accettare di morire di fame d’affetto. La condizione della piccola Michela nel collegio dietro casa è paragonabile a un esilio o, peggio, al sentirsi, da allora e per sempre, una straniera in patria, una reietta. Il sentimento di indegnità sarebbe potuto diventare il doloroso fardello della sua vita. Ma non è stato così. il suo daimon, la sua vocazione l’hanno tratta in salvo.
Hillman, ne Il codice dell’anima, si scaglia contro quello che definisce “il pregiudizio parentale”. Contro l’idea, cioè, che siamo “psicologicamente fatti”, in modo quasi meccanico, deterministico, dai nostri genitori. O dall’ambiente circostante. Dal suo punto di vista c’è un innato, dentro di noi, che è (o potrebbe essere) più forte dei condizionamenti che riceviamo da bambini. Qualcosa che c’è già, che egli chiama “la quercia nella ghianda”, e che noi possiamo salvaguardare, coltivare, far crescere...
Tra casa e collegio, su questo sottile crinale si è svolta la vita infantile di Michela. Tra l’essere amata in modo gratuito, per quel che era, e il dover dimostrare di essere brava per ricevere un encomio, un bel voto: il surrogato di un abbraccio. E la scrittrice che sonnecchiava in lei, sorretta dalla sua ghianda, è stata capace, superando il pericolo della scissione, di dare spazio a entrambe le esperienze attraverso il suo caratteristico modo di raccontare. La frase di Iréne Némirovsky: “Le infanzie felici creano una vita armoniosa. Le infanzie infelici una vita feconda” potrebbe essere posta a esergo di questo libro di Michela Gusmeroli.
Di qui il suo stile di scrittura, senza orpelli, né fronzoli, né abbellimenti. In una parola: asciutto. Non si evade né si patisce. Si sta. Anche nei passaggi più drammatici del racconto, non c’è spazio per il piangersi addosso, per il vittimizzarsi. Non ci si aggrappa all’illusoria speranza né si cade nella cupa disperazione. Un atteggiamento che ricorda la presa d’atto della realtà così com’è, e per quello che è, dello stoico. E tuttavia anche il più duro dei materiali, pur esposto nella sua cruda nudità, arriva al lettore sotto una luce filtrata dalla levità e dalla grazia. Forse si tratta del tocco di Giulia, l’alter ego mitico di Michela, la sua aristocratica sorella oscura che dall’alto della sua saggezza millenaria getta uno sguardo disincantato sulle cose.
Giulia è nata da una vacanza a Napoli (...). L’ispirazione mi è venuta leggendo la sua storia (...) A Ventotene ho cominciato a sentire che Giulia mi parlava.
La scrittura di Michela si muove al di sopra delle nebbie dell’identificazione e al di sotto delle irreali trasparenze di un sole invernale. Una scrittura che a me, lettore, crea una sensazione raramente incontrata: lucida e opaca al tempo stesso. Provo di più e comprendo di più, o, per meglio dire, diversamente. Si placa in me il conflitto tra l’irrazionale e il razionale, tra la pancia e la testa. Una vista neutra, nell’insieme, su un territorio dove il giudicare e il giudicarsi sembrano espunti. L’incanto del disincanto.
La scrittura di Michela è forse paragonabile al lavoro di un fenomenologo che si sforza di mantenere dialetticamente intrecciati, e senza mai farsi sopraffare ora dall’una ora dall’altra delle due polarità, l’oggetto e il soggetto, il narrato e il narrante, il reale e l’immaginario. Ciò porta il lettore a quello stato di ascolto e di comprensione profondi che Brecht chiamò straniamento.
Il desiderio è ciò che rende l’assenza più potente della presenza, direbbe Lacan. È il paradosso dell’amore. Di nuovo l’unione degli opposti. Sul culto dei morti si fonda la religiosità umana. E sulla religiosità l’amore. Amiamo ciò che ci manca, trasformando i nostri avi in divinità, mentre spesso ci dimentichiamo di chi ci sta vicino, facendolo a poco a poco precipitare nel buco nero dell’amnesia affettiva o nel giardino degli asfodeli dell’oblio, l’anticamera degli Inferi.
Così “la mia solitudine è piena di presenze” e, in seguito alla morte del padre:
Ma il Grande Silenzio che ha avvolto, quasi recluso, la sua persona, l’ha anche custodita.
E adesso la ritrovo sempre più presente, vicina.
Oppure, leggiamo, dopo un litigio con il marito:
Immaginò il corpo: particolari staccati, poi tutta intera la persona che le trasmetteva una sensazione più intensa del desiderio, più vasta dell’affetto. Era la pienezza, che spuntava silenziosa dentro di lei, quando lui non c’era.
Per concludere, vorrei mettere in evidenza un altro tratto paradossale della biografia dell’autrice: il suo lavoro alle Poste Italiane. Lo scritto di Michela Gusmeroli è zeppo di parole e sigle che, col passare del tempo e delle generazioni, tendono a diventare incomprensibili e che presto si aggiungeranno, come curiosi reperti archeologici, all’ascia di pietra nel museo delle cose scomparse: Milano Ferrovia-Telex-Salone delle Ordinarie-la Sette-Vaglia Risparmi-Ufficio Informazioni Centosessanta-Uffici di Movimento-Sala Apparati-Ispezione-Postacelere, solo per citarne alcuni.
Lei, che aveva a che fare con cartoline, lettere, raccomandate e telegrammi che le venivano ogni giorno rovesciati sulla scrivania, doveva tenersi saldamente aggrappata alla sua esile barchetta di carta fatta di parole, l’essenza della sua identità, per non essere sommersa da una marea di parole non sue, anonime, di tutti e di nessuno. E poi, beffardo destino, la morte annunciata dell’antico mezzo di trasporto delle parole: la carta. La lenta agonia delle parole “materiali” sostituite da quelle “incorporee” della comunicazione virtuale del mondo digitale.
Quanti libri come questo, fatti di carta, potranno ancora vedere la luce?
Saverio Falcone
.jpg)